Museo de la Evolución Humana
di Valentina Di Francesco
Percorrendo le rive del rio Arlanzón, attraverso l’antica cittadina di Burgos, in un preciso punto della sponda sud si volge lo sguardo oltre un leggero dislivello, una sorta di artificiale lieve collina erbosa, e si incontra un massiccio blocco di tre grandi volumi cristallini che compongono il complesso culturale della zona di Solar de Caballería: a nord maestosamente affacciato sul corso del fiume, e a sud incastrato nello stretto reticolo di vie del borgo castigliano.
Non si può entrare ma, soprattutto, comprendere il blocco principale del complesso – quello centrale dedicato al Museo de la Evolución Humana – senza prima aver proseguito il proprio percorso verso est, lungo il fiume, raggiungendo una grande e verde vallata chiamata Sierra de Atapuerca.
La Sierra de Atapuerca è una vasta area geologica caratterizzata da fenomeni carsici. La formazione della valle del fiume Arlanzón portò, intorno ad un milione e mezzo di anni fa, al ritiro delle acque che occupavano l’area e alla formazione di gallerie e grotte che vennero nei secoli utilizzate da animali e uomini preistorici.
Lo stratificarsi in parte dei sedimenti e la condizione protetta di certe gallerie ha preservato nel tempo i resti fossili dando vita a uno dei più importanti siti archeologici d’Europa: il sito degli scavi di Atapuerca. L’ampia area di scavo è caratterizzata da una particolare vegetazione e conformazione del terreno, inoltre l’attività umana ha nel corso del tempo modificato il paesaggio asportando fette di terreno e creando profondi tagli nel suolo carsico. Ripercorrendo il corso del fiume verso Burgos si ritorna dunque al dolce pendio erboso e all’ampio complesso cristallino che apparentemente ha ben poco a che fare con la matericità argillosa degli scavi di cui dovrebbe essere divulgatore.
La ricerca architettonica di Juan Navarro Baldeweg ha, nel corso degli anni, sempre più concretizzato la visione del soggetto architettonico come una «cassa di risonanza che trasforma segnali estranei ad essa per tradurli e adattarli alle condizioni di ricezione sensibile. L’architettura è come una parte della natura, come un paesaggio astratto dedotto da essa».
Attraversando dunque la grande vetrata, che avrebbe il presupposto compito di separare la realtà naturale dell’esterno, affacciato sul fiume, dalla chiusa realtà artificiale dell’interno, inaspettatamente ci si ritrova di fronte ad un nuovo ampio orizzonte lontano che permette di percorrere e intuire con un unico sguardo l’intero edificio. Un orizzonte disegnato e ordinato da grandi volumi rettangolari che il visitatore incontra immediatamente di fronte a sé e che corrono paralleli alla direzione dello sguardo. Una fitta vegetazione ricopre la sommità inclinata di tali volumi in continuità con il declinante manto verde del pendio esterno all’edificio.
La natura accoglie, imprevedibile, introducendo verso la profondità dell’interno e ciò che risuona tra queste bianche geometrie, pulite e lineari, è inaspettatamente l’intensità dell’esperienza dello scavo archeologico. Esse riproducono infatti, reinterpretandolo, l’orizzonte scavato del sito di Atapuerca divenendo una sorta di immaginario punto di incontro tra l’ambiente museale e la storica vallata e conducendo il visitatore nel corso dell’esplorazione del museo, trasformandosi di volta in volta in differenti tipologie di paesaggio.
Si può scendere nel profondo canyon, lì dove i volumi si innalzano trasformandosi in maestose mura sulle cui superfici si può leggere e comprendere il millenario disegno degli strati orografici sedimentatisi, accuratamente rappresentato e riprodotto attraverso semplici grafici e sottili linee stratificate. Una volta giunti alla base dei volumi si può entrare al loro interno, vivendo l’esperienza dell’ambiente buio e sospeso delle grotte che per secoli hanno ospitato i nostri antenati, o ancora, una volta usciti, si possono risalire le lunghe rampe laterali o le scalinate sospese che conducono ai vari piani dell’esposizione osservando così di lato e dall’alto il paesaggio riprodotto sulla sommità dei volumi: un ambiente vegetale che diviene una sorta di costante ambientazione, un punto di riferimento, uno sfondo generale al racconto del museo. Fasci di luce penetrano l’edificio e illuminano i visitatori che percorrono le rampe così come la vegetazione carsica – i faggi, i frassini, le querce, le piante aromatiche – piovendo dall’alto attraverso gli ampi lucernari che ricevono e diffondono la luce e filtrando lateralmente, dal tessuto esterno di grandi travi portanti incrociate.
L’importanza dell’architettura per Baldeweg non consiste nell’oggetto in sé ma nella capacità dell’oggetto di trasformare il messaggio in un’esperienza comprensibile dalla sensibilità umana,
così come la cassa di risonanza di un violino trasforma le onde sonore in note udibili e melodie. Lo strumento dell’architettura si attiva grazie all’esperienza,
ecco dunque come l’interpretazione da parte del visitatore dei grandi volumi che lo accolgono varia a seconda dei suoi movimenti nello spazio e come queste grandi geometrie, risuonando della eco di lontani paesaggi, divengono elementi fondamentali per condurlo lungo il percorso attraverso il museo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Museo de la Evolución Humana
Burgos, España, 2010
Juan Navarro Baldeweg
Con: José Manuel Méndez Pozo
In collaborazione con:
Direzione lavori: C. Bolívar Montesa, V. Vázquez Sequeiros, C. Calleja Perucho, M. Eizagirre Markaide, A. Hermosilla Minguijón, P. del Cid Mendoza, J. Ruiz Granados, J. Fernández Contreras, L. Alfaro Pérez, E. Barroso Alonso
Progetto: C. Bolívar Montesa, J. Bretón Lesmes, A. Solé Chamorro, E. Castillo Viguri, D. Marsinyach Ros, J. A. Bueno Bueno, E. Vivanco Antolín, P. Sánchez de Vega, J. M. García Fuentes, M. Guerra Pastrián, A. Merchán García, P. Pérez Ramos, I. González Galán, J. Fernández Contreras
Concorso: C. Bolívar Montesa, F. G. Pino, A. Levi, J. A. Bueno, V. González Rebollo, S. Streck, J. Bretón Lesmes
Foto di: Thomas Meyer
Articolo pubblicato su Lotus 146
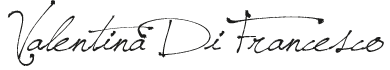

No Comments